Il continuo richiamo a “tradizioni” non meglio definite fa tanto pensare a un bisogno di appoggiarsi a qualcosa di rassicurante, anche se magari poco veritiera, piuttosto che avventurarsi nel terreno sconosciuto dell’innovazione.
Eric J. Hobsbawn, famosissimo storico britannico, scrisse un libro illuminante intitolato L’invenzione della tradizione. Cito una sua frase che lo introduceva: “Le “tradizioni inventate” sono l’insieme di pratiche che si propongono di inculcare determinati valori e norme di comportamento ripetitive nelle quali è implicita la continuità con il passato. Ogni società ha accumulato una riserva di materiali in apparenza antichi: per rinsaldare vincoli nazionali, per connotare la fisionomia di partiti e classi sociali. Questa sorta di ingegneria sociale e culturale ha caratterizzato l’affermarsi delle nazioni moderne, che hanno cercato di legittimare la loro storia più recente cercando radici nel passato più remoto”.
Che c’entra questo con vini e cibi?
Mi sembra evidente. Se leggete migliaia di interventi sui social su questi argomenti vedrete facilmente che tanti si appropriano di presunte “tradizioni” senza capire che in massima parte si tratta di forzature. Del resto, ci potrebbe essere persino un’interpretazione psicologica di questo. Ciò che riteniamo “tradizionale” ha a che fare con il passato, che più o meno conosciamo (o crediamo di conoscere), e quindi non ci provoca ansia e rappresenta qualcosa di rassicurante. Ciò che invece è “creativo”, “innovativo”, ci proietta in un futuro incerto e ansiogeno, mette in discussione aspetti tranquillizzanti e anche qualcosa che per alcuni sarebbe alla base della nostra appartenenza a una zona, a una comunità, a una “tradizione”, appunto.
Purtroppo, molto di tutto questo ha basi fragili. I vini che noi oggi beviamo, fossero anche tradizionalissimi, nascono a partire dalla seconda metà del Settecento e a Bordeaux in prevalenza. In Italia di vini “tradizionali”, imbottigliati e venduti almeno al di fuori della zona di produzione, se ne parla concretamente molto dopo. Noi abbiamo una “tradizione” contadina, agricola, e prima della fine della Seconda Guerra Mondiale chi imbottigliava e distribuiva i suoi vini rappresentava una percentuale molto limitata della produzione. Le Doc, che sono del 1963 come legge, ma che prima degli inizi degli anni Settanta erano rare e poco conosciute, sono state probabilmente il crinale fra il passato e il mondo che conosciamo oggi.
Talis pater… sia vini sia ricette
Stessa storia per ricette alle quali viene attribuita una “tradizione” che nella migliore delle ipotesi è di un secolo o giù di lì. Raffaele Esposito inventò la Pizza Margherita nel 1889, la Carbonara è il risultato della modifica di una ricetta forse abruzzese avvenuta a Roma nel 1944, e l’Amatriciana col pomodoro ha una storia simile. La prima ricetta di un “riso giallo in padella”, antesignano del Risotto alla Milanese è del 1809.
“Tradizioni”? Fate voi. Forse più commistioni di culture diverse. “Fusion” ante litteram. Con ingredienti e ricette che venivano da altre zone e da altre culture che poi hanno dato vita a ricette “tradizionali”.
Per i vini è lo stesso
Il Barolo come lo conosciamo oggi, nasce dopo la metà dell’Ottocento, il Brunello poco dopo, l’Amarone addirittura dopo il 1950. I vini erano sfusi e locali, le ricette soprattutto familiari, con mille sfaccettature e mille interpretazioni. Però c’è chi è sicuro che la Carbonara è solo col guanciale perché è “tradizione”. Quale non si sa bene, però fa sentire meglio chi lo afferma. Va bene così.
- La vignetta utilizzata per l’apertura è di Angelo Campaner, “Tra sogno e realtà”, tratta dal concorso di (eno)satira Spirito di Vino, edizione 2018, categoria Over 35, organizzato dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.

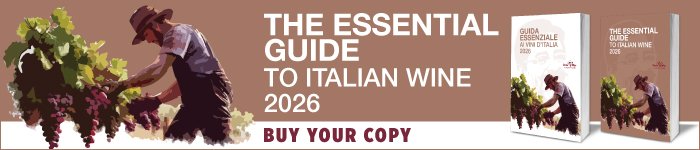



1 commento
La tradizione è una innovazione che ha avuto successo